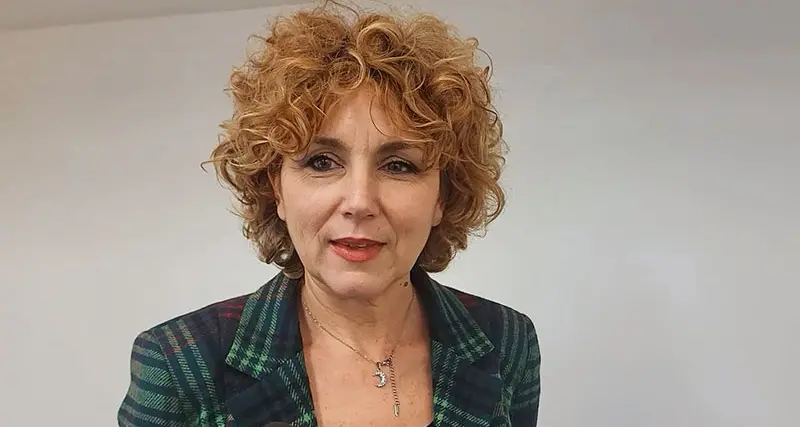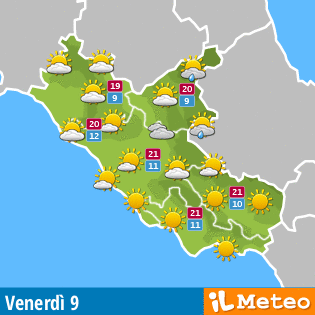ENRICO CIANCARINI
Avverto un forte ed intenso fastidio, arriverei a dire repulsione, quando un “foresto” confonde “le biscuttine di Civitavecchia” con i tozzetti viterbesi o con i cantucci toscani. Non c’è possibilità di paragone: la goduria della cioccolata e la giusta biscottatura sconfigge tutti!
Nel tentativo di scriverne la storia, la prima domanda a cui dobbiamo rispondere è perché li chiamiamo biscottini e non tozzetti come nel resto dell’Alto Lazio? Debbo premettere, che non essendo di “lingua madre civitavecchiese”, nel seguito dell’Almanacco parlerò di biscottini, utilizzando la forma in italiano.
Padre Alberto Guglielmotti nel suo illuminante Vocabolario marino e militare (1889) così definisce il “Biscotto. s.m. Crusca. Pane due volte cotto, per conservarlo lungo tempo e sano. Alimento dei marinari nei lunghi viaggi, e dei soldati nei lunghi assedi. Lo chiamano pur Galletta; e se magagnato o franto, Mazzamurro, e Tarallo”. Il nostro storico evoca anche la forma proverbiale “mettersi in mare senza Biscotto: senza il necessario a far checchessia”. Inoltre aggiunge che la Biscotteria è il “luogo, specialmente nei porti di mare, dove sono i forni per cuocere il Biscotto, e dove se ne fa la distribuzione”. Già il nome evoca una dolce favola.
I forni camerali, situati prima a piazza Leandra, poi edificati in via Granari, sfornavano ogni giorno quintali di biscotto destinati alla flotta papale ospitata nello scalo civitavecchiese. Spesso il biscotto civitavecchiese, considerato di buona qualità, era acquistato anche per la sussistenza di altre flotte italiane od europee.
Da biscotto a biscottino il passaggio fu breve: possiamo facilmente ipotizzare che dagli instancabili forni camerali quando si concludeva la produzione del biscotto, soprattutto nei giorni di festa, potesse sfornarsi qualche dolce per rallegrare le mense dei religiosi (domenicani e francescani), per gli ufficiali, i soldati e i marinai della flotta, per le loro famiglie, per qualche civitavecchiese con maggiori possibilità economiche. A Pasqua si sfornava la famosa pizza, a Natale era tempo dei biscottini.
Nelle Costituzioni del Conservatorio della Divina Provvidenza delle Zittelle Orfane, e dello Spedale delle Povere Inferme di Civita-Vecchia (1776) a pagina 47 si vieta che alle inferme siano somministrati da fuori “minestre, brodi, ristorativi, o altro”, ma “al più si potrà tollerare il regalo di pochi biscottini; ma questi dovranno essere consegnati alla Superiora, la quale non ne porgerà all’Inferma, che uno, o al più due il giorno, quando peraltro ne abbia avuto la permissione dal Medico”.
Cantucci e tozzetti trovano la loro origine nel XVI secolo, il Dizionario della fiorentina Accademia della Crusca li registra nel 1691 “biscotto a fette, di fior di farina, con zucchero e chiara d’uovo”. Le mandorle e le nocciole arrivarono più tardi.
Ma la peculiarità del nostro biscottino di Natale è la generosa e goduriosa presenza della cioccolata. Senza di essa sarebbe il solito tozzetto arricchito solo dalle mandorle e nocciole.
Perciò, la seconda domanda che dobbiamo porci, è quando il biscottino civitavecchiese incontrò e abbracciò la cioccolata trasformandosi in uno dei più golosi dolci italiani? Il primo europeo ad assaggiare il cacao fu Cristoforo Colombo che lo portò in Spagna ad inizio XVI secolo. A Roma la cioccolata si affacciò nel 1685. Quando arrivò a Civitavecchia? Certamente negli stessi anni, dato che il cacao o la cioccolata destinati al mercato capitolino sbarcavano in prevalenza nel porto tirrenico.
Il frate domenicano Jean Baptiste Labat nelle sue cronache civitavecchiesi (F. Correnti e G. Insolera, I viaggi del padre Labat dalle Antille a Civitavecchia. 1693-1716, 1995) ricorda che a casa dell’assentista Giulio Pazzaglia, durante un sontuoso banchetto a cui fu invitato appena arrivato a Civitavecchia (gennaio 1710), fu servito “un grande cabarè della Cina pieno di tazze di cioccolata. Si diede ad ogni convitato un piattino con un cucchiaio di vermeil e un fazzoletto di seta. Dopo la cioccolata fu portato il caffè e successivamente dei liquori con dei marzapani”.
Padre Labat prima di giungere a Civitavecchia aveva visitato le Antille dove poté apprezzare la cioccolata preparata dagli indigeni. Di questa esperienza parlò nelle sue memorie e moltissimi testi settecenteschi riportano le sue osservazioni sul cacao e la cioccolata. Cesare Cantù nella sua Storia Universale (1843) ricorda che padre Labat “si fece apostolo della cioccolata, e pretendea farne un alimento popolare a un soldo la tazza, asserendo che il cacao della Martinica vi basterebbe: ma non riuscirono i suoi sforzi”.
Sforzi che invece ebbero successo a Civitavecchia? Possiamo fantasticare che il buon frate domenicano amasse inzuppare i biscottini (ancora tozzetti) nelle fumanti tazze di cioccolata? E così, da lui francese, i nostri biscottini diventano “le biscuttine”? Oh, si scherza, naturalmente.
Da sottolineare che il consumo della cioccolata, essendo liquida, fu ammesso dalla Chiesa durante i frequenti e lunghi periodi di digiuno, anche se ci furono accese polemiche teologiche su questa concessione accordata da papa Pio V nel 1569.
Fra i regali con cui la città ossequiava i pontefici in visita a Civitavecchia, la cioccolata è sempre presente. Antigono Frangipani nell’Istoria dell’antichissima città di Civitavecchia (1761) cita la cioccolata fra i doni che il “Sig. Maceroni affittuario delle Lumiere” fece a Benedetto XIV quando fu in visita a Civitavecchia nell’aprile del 1746. Compulsando la lista dei doni offerti al pontefice riportata nel Ritratto istoromanzico della venuta in Civitavecchia di Papa Clemente XIII l’anno 1762 scritto da Pietro Arata dilettante civitavecchiese (edizione critica a cura di Odoardo Toti, 2013) si possono trovare alcuni degli ingredienti dei futuri biscottini civitavecchiesi: cioccolata, vaniglia, canditi, zucchero, burro.
A Civitavecchia, fra XVIII e XIX secolo, sbarcavano merci da tutto il mondo destinate al mercato romano, tanto che molte imprese commerciali della Capitale aprirono succursali in città per gestire tali traffici. Fra le merci più richieste e perciò più costose vi erano i generi coloniali, cioè il caffè e il cacao. L’economista spagnolo Cristoforo Molto nel 1781 pubblicò le Osservazioni economiche a vantaggio dello Stato Pontificio in cui denunciava “la forte incidenza della diffusione dei beni di importazione, soprattutto caffè e cioccolata, sulla bilancia commerciale dello Stato pontificio”. (Cecilia Carnino, Lusso e benessere nell’Italia del Settecento, 2014). Nel 1850 la Camera Apostolica stimava in un milione di scudi il valore di questo import.
È difficile se non impossibile fissare la data precisa in cui nacque il biscottino di Natale civitavecchiese guarnito dalla cioccolata. Negli ultimi decenni del Settecento si registra nello Stato pontificio una discreta ma artigianale produzione di dolci a base di cioccolata, Ad inizio Ottocento il progresso tecnico e gli studi di alcuni benefattori dell’Umanità permisero la produzione a livello industriale della tavoletta di cioccolata e il loro uso diffuso in pasticceria e nei prodotti da forno.
Nella nostra città il consumo di cioccolata fu costante e documentato. Nel 1901 un almanacco spagnolo registrava che a Civitavecchia in quattro importavano cioccolata: Cesare Baldassarri, i Fratelli Costa, Luigi Manzi e Domenico Legnani. Nel 1908 risulta esserci una fabbrica di cioccolato di proprietà dei Fratelli Legnani. Sicuramente erano presenti altri laboratori che producevano cioccolata.
Ogni famiglia doc civitavecchiese sforna già da novembre i biscottini e le ciambelline per Natale. Se la pizza di Pasqua ha avuto una diffusione commerciale anche nazionale tanto da farla annoverare fra i più celebri dolci italiani, il biscottino di Natale sembra appartenere più alla sfera domestica, quella più identitaria e strettamente legata alle tradizioni serbate da ogni famiglia.
Non essendo civitavecchiese doc mi affido al cantore per eccellenza della buona “civitavecchiesità”, l’amico Carlo De Paolis, per concludere questo almanacco dedicato al biscottino, monumento alla golosità, citando l’inizio della poesia Er mare de Leandro in cui si evidenzia il suo legame con Civitavecchia:
“De bbiscuttine s’è ‘mprofumato er mare de Leandro - Natale adè vicino”.
Ne approfitto per porgere a tutti i Civitavecchiesi i miei migliori auguri di buon Natale festeggiato con “le biscuttine”.