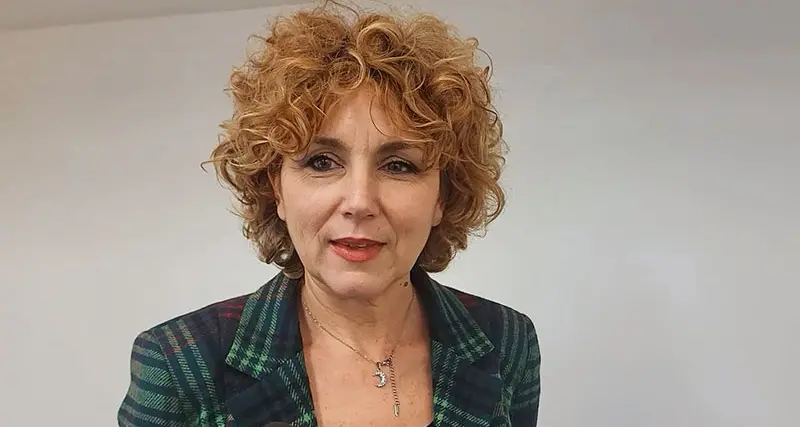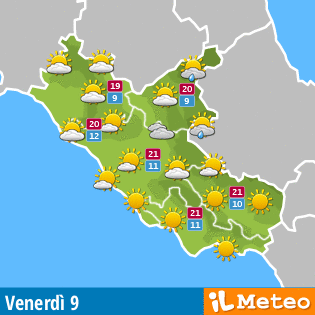TARQUINIA – Il Pantheon degli Etruschi deve essere ridisegnato mettendo in alto l’est.
Nuova straordinaria scoperta quella dello studioso Alberto Palmucci, luminare della storia etrusca e autore di numerosi libri di settore, che offre una rivoluzionaria teoria che di fatto reinterpreta completamente la scienza aruspicina, quell’arte divinatoria di origine etrusca che consisteva nell’esame delle viscere, soprattutto fegato ed intestino, di animali sacrificati per trarne segni divini e norme di condotta. L’arte aruspicina si basava sulla determinazione del templum, ovvero lo spazio sacro su cui si proiettava la suddivisione della volta celeste. Questa si ipotizzava attraversata da due rette perpendicolari: cardo (direzione nord-sud) e decumano (direzione est-ovest). Partendo dalla linea del decumano e andando verso est si delimitava la pars familiaris, dove cioè risiedevano gli dèi benevoli, fra cui Tinia e sua moglie Uni; mentre verso ovest si faceva risiedere la pars ostili, dove cioè venivano collocati gli dèi ostili, ovvero gli dèi dell’oltretomba.
Ebbene, secondo la rivoluzionaria teoria del professor Alberto Palmucci la posizione di quello che fino ad oggi si è ritenuto essere stato l’ovest per gli Etruschi, in realtà appartiene all’est. Il rimescolamento dei punti cardinali elaborato da Palmucci conduce ad una nuova interpretazione della volta celeste e delle case degli dèi e quindi dello stesso tempio etrusco. Palmucci analizza tre fonti primarie: lo specchio di Tagete (IV sec. A.C), preziosa testimonianza dell’epoca, che raffigura proprio la scena (che peraltro il mito ambienta a Tarquinia) della lezione di aruspicina impartita da Tagete a Tarconte; il fegato di Piacenza, modello bronzeo rinvenuto a Gossolengo nel 1877, nel quale sono riprodotti, nel bordo esterno, i sedici punti cardinali del cielo etrusco con i nomi delle relative divinità; e infine la divisione del cielo etrusco elaborata da Varrone.
Lo studioso, noto nel territorio anche per aver trascorso la sua giovinezza a Civitavecchia, dove ha anche insegnato, ha svolto per lunghi anni attività di ricerca filologica su Virgilio e Corito-Tarquinia presso l’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Liguria. Appassionato di Etruschi, ne ha studiato la storia e la lingua, fino a stravolgere completamente la teoria dell’archeologo Massimo Pallottino che nel ricostruire il pantheon etrusco avrebbe semplicemente attribuito agli Etruschi quanto dicevano i Romani. «Furono i romani – spiega infatti il professor Palmucci – e non gli Etruschi a posizionare il nord nella parte alta del cielo. Quindi, tutti coloro, compreso Pallottino, che posero il nord nella parte alta delle mappe sono in errore».
Lo studio, documentato, e che appare essere una scoperta di eccezionale importanza, viene riportato nel libro di Palmucci ‘’Aruspicina etrusca ed orientale a confronto’’ (Roma 2013) ed è anticipato anche nella sua precedente opera ‘’Gli etruschi di Corneto’’ peraltro oggetto di un recente premio conferito al professore dal Comune di Santa Marinella ad agosto.
Incrociando e sovrapponendo le scritte e le informazioni contenute nel ‘’Fegato di Piacenza’’ e nello ‘’Specchio di Tagete’’, il professor Palmucci ricostruisce il Pantheon etrusco ricollocando ad est, nella parte alta, gli dèi buoni e ad ovest, in basso, gli dèi delle tenebre. La vera intuizione risiede nella identificazione, mai avvenuta prima d’ora, del fegato che tiene nelle mani Tagete sulla scena dello specchio, con quello di Piacenza. La coincidenza di forma, segni e posizione ne darebbe ampia dimostrazione. «Le parti coincidono – dice Palmucci - ha le stesse caratteristiche. La scena riprodotta nello specchio di Tagete riporta quello che era già descritto nel fegato di Piacenza».
«L’analisi scientifica delle due immagini - spiega il professore, le cui dichiarazioni su internet stanno suscitando forte attenzione tra chi sposa la sua teoria e chi la contesta -, ci fornisce un nuovo quadro che reinterpreta le figure stesse degli dèi degli Etruschi. Gli Etruschi – spiega il professor Alberto Palmucci – non si orientavano come noi con il nord, ma si orientavano con l’Oriente e ci sono le prove archeologiche». «Secondo gli Etruschi – aggiunge Palmucci - il fegato delle vittime sacrificate rispecchiava il templum, cioè il pantheon. In altre parole rispecchiava l’universo. L’archeologo Pallottino ha ricostruito il Pantheon etrusco posizionando il nord in alto, ma ha travisato ciò che c’è scritto sul ‘’Fegato di Piacenza’’. Lungo il bordo del fegato ci sono sedici nomi di dèi inseriti dentro sedici caselle e ciò perché gli Etruschi dividevano il cielo in sedici parti».
«Nello specchio etrusco si vede chiaramente – spiega Palmucci – che Tagete stesso ha le spalle ad est e che questo era l’orientamento col quale gli aruspici posizionavano le varie parti del loro cielo e la relativa posizione delle case dei loro dei. La parte sinistra del cielo (est-sud-ovest) era quella favorevole. Infatti qui è raffigurato Veltun». «Esaminando la scena dello specchio (decorata nella superficie retrostante l’oggetto) – entra nello specifico Palmucci -, si vede la rappresentazione del giovane Tagete (che il mito vuole essere uscito dalla terra mentre Tarconte arava) situato in posizione accanto a Veltune, il dio della federazione etrusca, (in latino Voltumna) che lo assiste. C’è scritto Pava Tarches, giovane Tagete e Veltune assiste Tagete; c’è poi una donna (Uchernei o Uchernet), e Tarconte, il famoso fondatore di Tarquinia (Avle Tarcunus). Si individua anche il dio Rathlth che significa nel luogo del dio Rat. Ma soprattutto – fa notare Palmucci - guardando Tagete si vede che il sole nasce alle sue spalle. Ecco il primo indizio: da qui si capisce che in alto c’è l’aurora, e quindi non il nord, che guida la quadriga dei cavalli del sole. Passando dallo specchio al fegato di Piacenza si ritrova l’est in alto, perché, messi a paragone, i due fegati e i due tipi di orientamento coincidono. Se Tagete ha alle sue spalle l’oriente, anche il fegato ha alle spalle l’oriente e l’est, quindi davanti c’è l’ovest. Il fegato di Piacenza, inoltre, è diviso in due: Tagete nello specchio ha in mano il bozzo che si trova ad est nel fegato di Piacenza, il centro del fegato. Alla sinistra di Tagete, pende la parte sinistra del fegato».
Questa nuova interpretazione non sarebbe quella descritta da Pallottino, seguito da un serie di discepoli. «Pallottino – ribadisce Palmucci - ha trasferito agli Etruschi le caratteristiche del templum romano. Ma non è corretto. Mette il nord dove invece io ritengo ci sia l’est. Sbagliando la collocazione dei punti cardinali, Pallottino sbaglia a sua volta tutte le dimore degli dei e quindi sbaglia tutta la ricostruzione del Pantheon. Lui è portato ad identificare nella parte che ritiene essere il nord, gli dei negativi, quasi la morte, perché il nord per gli etruschi era la morte. Prima di interpretare il fegato di Piacenza con il modo con cui gli antichi romani interpretavano il pantheon, Pallottino avrebbe dovuto meditare sulle fonti etrusche e non su quelle romane. Io posso dimostrare che in quelle zone in cui Pallottino colloca l’ovest ci sono in realtà divinità positive. Seguendo le scritte riportate sul fegato di Piacenza e trasferite nella stessa posizione, sul Pantheon troviamo la residenza della dea Culson, dea che apriva le porte; poi c’è Vetisl, invocato dagli etruschi prima dell’alba. Quindi è chiaro che questo è l’oriente. Subito dopo il punto dell’est c’è Cilensl (fato, destino) cioè la dea Fortuna, che anch’essa si colloca all’alba. Pallottino invece la identifica come un dio notturno, ponendola ad ovest. Poi c’è Tin, abbreviazione etrusca del dio Tinia, divinità etrusca che significa luce e giorno (Giove), quindi è chiaro che siamo all’alba. A sud viene poi collocata Giunone, che per gli Etruschi era la dea del calendario. E proprio il calendario per gli etruschi iniziava con il mese di giugno (da Giunone in etrusco Uni) con il quale cominciava l’estate (Uni era la dea del mezzogiorno). Ad Ovest, si trova Nethun, il dio del mare e accanto al mare c’è Catha, il nome del dio del sole che tramonta: quindi siamo ad ovest. Accanto c’è poi Fufluns, cioè Bacco, che è un dio autunnale. Ciò dimostra che sono rispecchiate anche le stagioni: ad est c’è la primavera, ad ovest l’autunno, a nord l’inverno e a sud l’estate».
A chiudere il cerchio di una rielaborazione in cui tutto coinciderebbe, ci sarebbe per Palmucci anche la famosa dichiarazione di Varrone riportata da Frontino nel De Limitibus: «Gli aruspici divisero il mondo in due parti e chiamarono destra quella che sta sotto Settentrione, sinistra quella che sta sotto la parte meridionale della terra andando da Oriente ad Occidente, poiché è di là che il sole e la luna guardano». Varrone disse anche che nel cielo «le parti del templum sono quattro e si chiamano: sinistra dall’est, destra dall’ovest, anteriore fino al sud e posteriore fino al nord. Sulla terra si chiama templum il luogo delimitato con determinate formule, al fine di trarvi i presagi o predervi gli auspici». (De Lingua latina, VII,7). (a.r.)
«Pantheon degli Etruschi: in alto c’è l’est»
LA SCOPERTA. Nuova interpretazione della scienza aruspicina. Lo studioso Alberto Palmucci ricostruisce un diverso schema dei punti cardinali, della divisione del cielo e delle case degli dèi. “Pallottino sbagliava. Basta vedere Tagete, nella famosa raffigurazione nello specchio: tiene in mano lo stesso fegato rappresentato nell’opera bronzea di Piacenza”
21 settembre, 2015 • 21:32