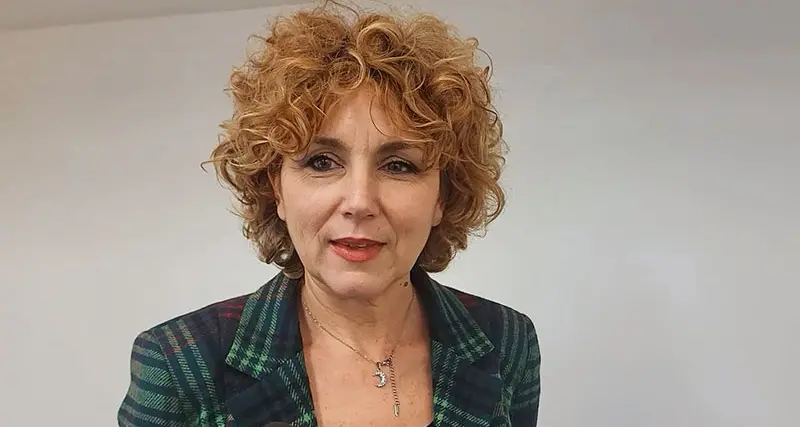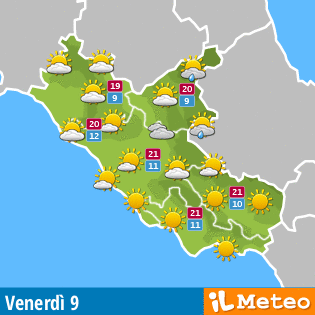di CARLO CANNA
CIVITAVECCHIA - Dalle reminiscenze bibliche, l’ottava delle dieci piaghe d’Egitto, l’invasione delle locuste è un fenomeno documentato frequentemente nelle aree mediterranee tra XIV e XIX secolo, come dimostra il bel saggio di Elina Gugliusco e Giuseppe Restifo dal titolo “La piaga delle locuste. Ambiente e società nel Mediterraneo d’età moderna” (Giapeto Editore 2014). In Italia, nell’alto Lazio, tra le altre, si ricordano quella che nel 1576 colpì il territorio di Tuscania e quella che nei primi del 1800 interessò l’Agro Romano e le aree limitrofe fino ai territori di Tarquinia e Monte Romano. Un interessante articolo di Maria Lidia Perotti, riportato sul bollettino della STAS del 1979, si sofferma proprio sui territori dei due comuni laziali, meno colpiti dal fenomeno, che probabilmente non intaccò le colture ma rappresentò comunque un problema per l’epoca impegnando per diversi mesi uomini, energie e mezzi nel difficile tentativo di “estirpare” le numerose “uovaja” dei fastidiosi insetti. Le aree colpite furono il cosiddetto “Pascolare” di Monte Romano detto “la Turchina”, e la confinante Tenuta della Turchina, appartenente al Principe Borghese. Il 22 marzo 1810, il Prefetto del Dipartimento del Tevere, Tournon, invia al sindaco di Corneto (l’odierna Tarquinia), Francesco Maria Boccanera, una circolare in cui quest’ultimo veniva invitato a comunicare tempestivamente ai proprietari terrieri le seguenti misure da adottare per la distruzione delle uova: “…1° quello del rimuovimento della terra con qualunque siasi istrumento agrario per lasciare con questo mezzo gli uovi esposti alla intemperie dell’aria, ed alla voracità degli animali, 2° quello della introduzione degli animali neri (maiali) nei luoghi sospetti, permettendo, che questi coi loro grifi rimuovano il terreno, e pongano a sacco le uova deposte, 3° quello della reperizione a mano dei nidi, ossiano covi delle uovaja per radunarli presso qualche riviera, e quindi o distruggerli col fuoco, o annegarli nell’acqua…”. Il mancato rispetto di tali indicazioni da parte dei proprietari terrieri sarebbe stata punita severamente. Non dobbiamo dimenticare infatti che all’epoca il problema era preso molto seriamente in quanto si riteneva che l’invasione delle locuste rappresentasse non solo un pericolo per le colture ma, ancor di più, un problema di salute pubblica dovuto al cosiddetto “veleno contagioso” che si sprigionava dall’immenso numero di insetti morti. Nella circolare, infatti, si precisa di bruciare la paglia per la distruzione delle uova “avvertendo di osservar la distanza da luoghi abitati o dalle macchie”. Così, il 10 maggio del 1810, il primo cittadino dell’antica città etrusca raduna i principali proprietari terrieri nella segreteria comunale e si decide di intervenire sia nelle aree in cui gli insetti si trovano ad uno stadio di crescita avanzata, mediante l’utilizzo di tendoni per intrappolare le cavallette, sia in quelle dove sono presenti solo le uova, recuperandole a mano e bruciandole. Il giorno seguente viene presentata una relazione in Comune dove risulta che nella tenuta della Turchina della Casa Borghese è presente una minima quantità di insetti, mentre la presenza dei fastidiosi ortotteri è ancora considerevole nella tenuta del Santo Spirito, e più precisamente nel Pontone delle Fornaci, nel cosiddetto “Pascolare”, nel Pontone del Cavalluccio e nelle piane confinanti con l’Ancarano. Così se la tenuta Borghese in soli due giorni è libera dagli insetti, in quella del Santo Spirito, le operazioni risultano assai più difficoltose, ostacolate peraltro dalla pioggia che impedisce la combustione della paglia per eliminare il gran numero di uova presente in alcuni punti. La gravità della situazione è tale che viene celebrata persino una funzione religiosa in onore della “Madonna delli grilli”, venerata nella Chiesa Cattedrale dal 1653. Nel corso della seduta del 19 maggio, viene evidenziata l’inattività delle operazioni messe in atto nel territorio di Monte Romano, che risulta ancora pesantemente infestato nella macchia e nella tenuta dell’Ancarano, considerate come la sorgente della presenza residuale di insetti nella tenuta Borghese. Sappiamo infatti che in questo momento le locuste risultano quasi del tutto scomparse nel territorio di Corneto, mentre quello di Monte Romano è ancora talmente infestato da rendere vano qualunque tentativo messo in atto dagli agricoltori. La relazione giunge al tavolo del sindaco di Monte Romano, Andrea Castiglia, la cui risposta, indirizzata al sindaco di Corneto, non tarda ad arrivare: “Strana per verità non meno che capricciosa sembrami la relazione che Le viene fatta, non so da chi, che le locuste nate in questo mio territorio vengono ad infettare il suo. Come che fossero contrassegnate da un fiocco rosso, e che io le potessi guidare a guisa di pecore ove più mi piaccia. Dica piuttosto che le di loro operazioni hanno consentito in molti congressi e poche operazioni ...”. Le operazioni intanto continuano nella tenuta Borghese e in quella del Santo Spirito e il 18 giugno il numero degli insetti risulta di molto diminuito. Il danno alle colture, almeno per Corneto, sembra del tutto scongiurato. Negli anni seguenti, restano invece ancora piccole quantità di locuste, soprattutto nella tenuta di Santa Maria, ma in quantità talmente minima da non destare preoccupazioni. Così, mentre nell’Agro Romano, ben più colpito dal fenomeno, le operazioni dureranno per diversi anni fino al 1815, nei territori di Tarquinia e Monte Romano il problema sarà quasi del tutto risolto nel giro di pochi mesi. Le spese sostenute dal Governo per l’eliminazione delle locuste furono rilevanti: si stima che solo nel 1811 vennero spesi circa 45.000 scudi per l’Agro Romano e 13.000 per i Comuni.
Riferimenti bibliografici: Perotti M.L. 1979; E. Gugliusco- G.Restifo 2014